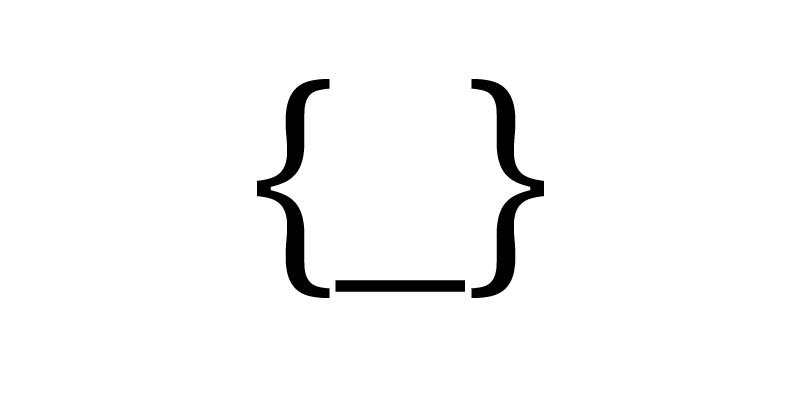Bastardo che mi rubi il sonno, se qui con me. Mille passi più lontano, sempre con me. (Casino Royale)
20 maggio
La sera del 19 maggio 2012 andai
a letto con un dubbio. Il giorno dopo avrei festeggiato il mio compleanno.
Certo, avrebbe piovuto, come sempre del resto quando decidevo di festeggiarlo
all’aperto con gli amici ma, soprattutto, non sapevo se offrir loro prosecco o
Franciacorta.
Alle 4.03 sciolsi il mio dubbio.
Fui svegliato di soprassalto da
un boato. Aprii gli occhi ed era nero, un nero totale. Ok, la vista era fuori
uso, dovevo fare affidamento solamente su udito e tatto. Il boato continuava e Cristina, di fianco a me, cominciò ad urlare. Ma non erano vere e proprie urla,
no. Era quella voce, la sua voce, quando le cadono tutte le difese. La voce più
brutta che io avessi mai potuto sentire ed in quel momento ero più che
consapevole che lo fosse, la più brutta. Una voce sfigurata che in un attimo ti
fa capire che devi farti forza anche per lei perché lei, in quel momento, è in impasse
totale.
Furono secondi, tuttora non so
nemmeno quanti, in cui di quel buio totale ricordo solo un assordante bom bom bom. Bom. Bom. Bom. Un gigante
che scuoteva la tua casa, quasi volesse sradicarla dal terreno: io me lo sono
immaginato così.
Ok, era terremoto. Come non
l’avevo mai sentito. Forte, molto forte, stranamente fortissimo. D’istinto mi
fiondai sopra Cristina in un impulso naturale di difesa. Le dicevo di stare
calma, che sarebbe finito. Ma non finiva, non era come solito, non finiva. In
quegli istanti non avevo paura: non era coraggio, era non rendersi conto di
cosa stava succedendo. Mi fidavo del tetto sotto cui ero. E, in un certo senso,
dovevo fidarmi.
Poi finì.
Quelli successivi furono attimi
concitati. Ci alzammo, lei voleva uscire da quella casa. La luce non andava
così usai il telefono per farmi strada. Non sapevamo nemmeno l’ora così uscimmo
in pigiama, senza occhiali, senza nulla. Non era il compleanno che pensavo.
Ricordo gli allarmi delle case,
delle auto, di tutto. Un suono monotono programmato all’infinito. Il cielo era
identico a sempre, illuminato solamente dai lampeggianti degli allarmi.
Ricordo che provai sorpresa nel
vedere gente smarrita uscire dalle proprie case. Pensai che non stava succedendo una cosa normale, un qualcosa – come dire? – già
vissuto e su cui basarti per agire correttamente. Era un evento nuovo,
totalmente sconosciuto.
Io dovevo tornare in casa.
Eravamo entrambi senza occhiali - maledetta miopia - e solamente in pigiama. La
luce continuava a non funzionare per cui, sempre col telefono, salii le scale e
presi le prime cose che mi capitarono tra le mani. Mentre salivo cercavo di
illuminarmi intorno per vedere quello che era successo. I libri erano quasi
tutti caduti, la cucina era un disastro, vetri dappertutto. Cazzo, pensai:
quella era la mia casa. Com’era
possibile una cosa così nella mia casa?
La via si
era riempita, cominciava ad albeggiare. Il cielo era sempre lo stesso, e la luce
di un sole basso ed il passare del tempo rendevano concreto quello che era
appena successo: macerie. Le tue
macerie. Il centro del tuo paese. Tuo. Non bastò un irrefrenabile moto d’incredulità
per far fronte a quello straripante schieramento di concretezza. Ecco cosa
accadeva quando non vedevi più le sventure dall'alto del tuo culo al caldo.
Accadeva quello. E non c'era altro da dire.
Dormii in
auto la notte successiva. Ricordo che pioveva, piovve tutto il giorno. Dopo un
terremoto piove sempre, no? Da solo, nell’abitacolo, in un’ora imprecisata di
quel 20 maggio, nel giorno del mio compleanno, i vetri appannati, l’umidità
devastante, le gambe anchilosate, ancora non mi capacitavo dell’accaduto. Non
me ne capacitavo nonostante l’auto continuasse a ballare ad ogni scossa. In
quei momenti pensavo a ciò che era ovvio: il terremoto era il nemico perfetto,
imbattibile. Un nemico invisibile di cui non potevi prevedere le mosse, solo
subirle.
29 maggio
La
mattina del 29 maggio ero in ufficio a Modena; erano le 8.58 quando il collega
di fronte a me fece una telefonata. Alle 9.00 mi guardò e disse: questo è
terremoto? E mise giù il telefono.
Ricordo
che mi alzai con una calma inaspettata e mi misi sotto una parete portante. Ero
a Modena, a quaranta chilometri da casa mia: quello che si sentiva era nulla a
confronto di nove giorni prima. Vedevo gente correre giù per le scale urlando,
piangendo. La stessa che i giorni precedenti mi diceva che noi, gente della
bassa, dovevamo avere il coraggio di tornare in casa perché in questi casi
bisogna tirare fuori le palle: vaffanculo. Con tutto il cuore.
Anche
quella fu infinita, lunghissima. Tentai di chiamare ma niente, tutto fuori uso.
Uscii dall’ufficio e mi diressi verso casa continuando inutilmente a cercare di
mettermi in contatto. Nel frattempo per radio sentivo che l’epicentro era a
Medolla, che erano crollate delle fabbriche, che c’era gente sotto. Cristina
era al lavoro. A Medolla.
Apnea.
Non
saprei descrivere quegli attimi. Sono attimi in cui la razionalità desiste ma
non c’era rabbia al suo posto. No, non c’era nulla. Una sola, lunghissima, infinita,
apnea. Pensai alle cose più brutte. Poi pensai che non dovevo pensare alle cose
più brutte. Acceleravo. Poi accostavo per lasciar passare i mezzi di soccorso.
Acceleravo. Accostavo. Dovevo raggiungere il prima possibile l’azienda di
Cristina. Apnea. Acceleravo. Accostavo. Una chiamata, un numero fisso
sconosciuto: Cristina, dal lavoro, stava bene. Era viva. Non avrei mai pensato
di dire a Cristina: sei viva! Sei. Viva.
Accostai
di nuovo, per me. Ricordo solo che ripresi tanto di quel fiato in corpo che i miei
polmoni tornarono a vivere.
Giugno
Il giugno
2012 fu un giugno snervante. Il sole e l’estate incalzante si contrapponevano
alla desolazione delle macerie in un ossimoro annichilente. Mi svegliavo la
mattina nell’umidità della tenda, facevo colazione sotto la tettoia che avevamo
allestito a soggiorno e partivo per Modena. Il mondo cambiava. Tutti i giorni: desolazione-normalità-desolazione.
Entrare
in casa a fare la doccia significava preparare i vestiti pronti già per essere
infilati, minimizzare il più possibile il tempo di permanenza sotto l’acqua,
soprattutto per il lavaggio dei capelli che
poi se hai il sapone davanti agli occhi e viene una scossa non riesci ad uscire,
pensare alla via migliore per scappare nel caso una scossa mi avesse colto in
quell’attimo. La sfida con me stesso, ogni sera, era rimanere più tempo sotto
la doccia.
Bestemmiai
come non mai in quel periodo. Ma ormai anche le bestemmie avevano perso quel
gusto di proibito. Anche inventarne di nuove non dava più soddisfazione. Ormai
la bestemmia era scontata.
Ogni
persona reagì nel suo modo e molte persone reagirono in un modo inaspettato.
Chi si era sempre dimostrato forte spesso vacillava, l’impotenza verso il
terremoto atrofizzava la loro audacia. Le persone erano all’erta, all’erta
costante. Personalmente non ebbi mai paura per me stesso bensì per gli altri. Non per una spiccata dose di ardimento, sia
chiaro, quanto per una forma tremenda – qualcuno potrebbe definirla egoista –
di fastidio nel caso fosse successo qualcosa ad uno dei miei cari.
La
“gente”: tutti si ritrovarono geologi, geotecnici, strutturisti, ingegneri, psicologi,
psichiatri, economi, fisici. Tutti esperti all’opera. Un’ignoranza dilagante,
sconcertante, svilente. “Tra mezz’ora arriva una scossa e sarà ancora più
grande” urlavano a gran voce: teste di cazzo, non avrò mai sufficienti epiteti
per apostrofarvi.
Luglio
Tornai
definitivamente a dormire nella mia casa il 25 giugno.
Il primo
luglio era appena terminata la finale degli Europei: 3,2 Richter. Cristina non
ne volle sapere: tenda. Io stetti male, vomitai tutta la notte. Crampi allo
stomaco da rotolarmi in terra dal dolore, il capolavoro della somatizzazione. Come
ritornare al punto di inizio.
Sempre
Da quel primo
luglio ce ne furono altre di scosse. Ma da quel giorno non ho più abbandonato
il mio letto. E al boato di una scossa mi sveglio bestemmiando, poi mi corico e
ricomincio a dormire. Perché la paura ha un suo suono che ognuno di noi porta
con sé. Per me la paura è quel boato indefinito che per sempre porterò in
memoria. Ma cerco di non pensarci.
Certe cose lasciano segni indelebili. Io me ne accorgo, per esempio, quando sposto inconsciamente una bottiglia dal bordo al centro del tavolo e penso: sia mai che venga un terremoto, così non dovrebbe cadere in terra.
Certe cose lasciano segni indelebili. Io me ne accorgo, per esempio, quando sposto inconsciamente una bottiglia dal bordo al centro del tavolo e penso: sia mai che venga un terremoto, così non dovrebbe cadere in terra.